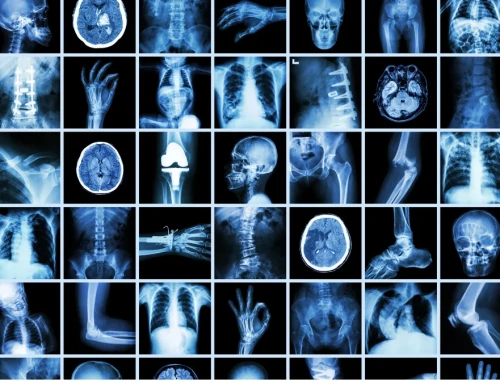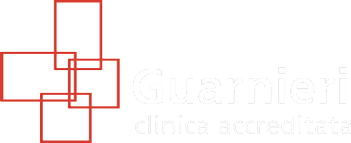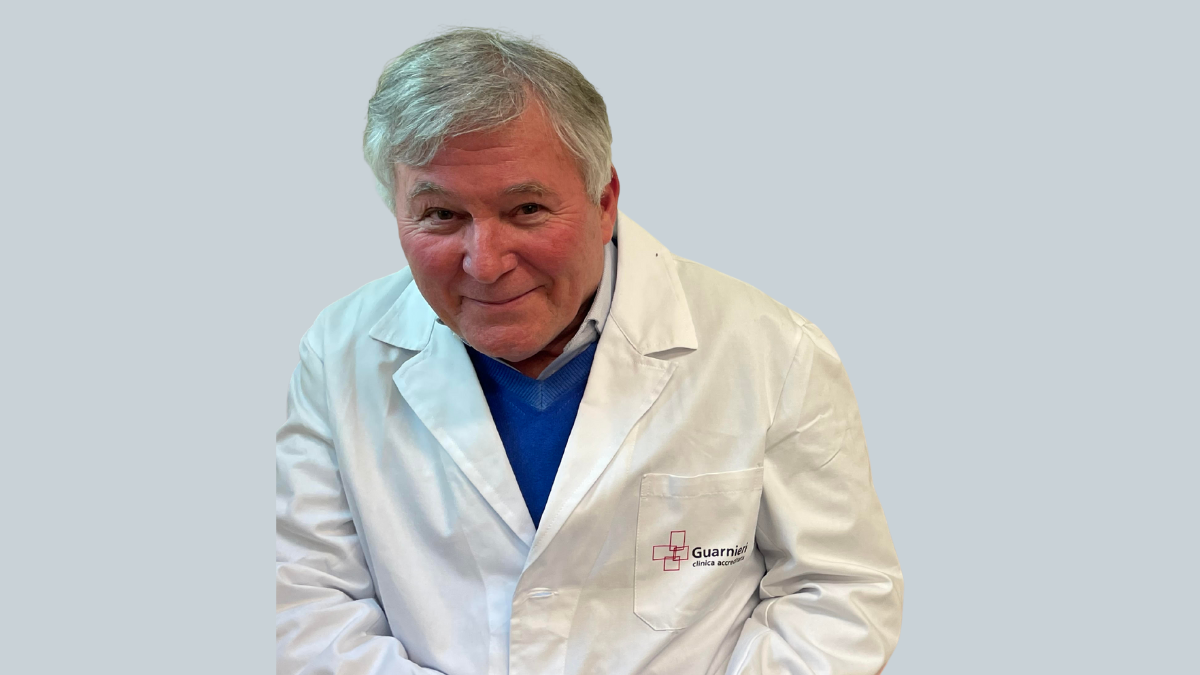
Articolo del 20/02/2023
L’arteriopatia periferica è una condizione che solitamente colpisce gli individui adulti, in particolare dopo i 50-55 anni di età, e la sua incidenza tende ad aumentare con il passare del tempo.
Questa patologia si caratterizza per la riduzione del flusso sanguigno (e quindi dell’apporto di ossigeno) alle estremità inferiori, e più raramente alle estremità superiori, a causa dell’occlusione o della restringimento delle arterie.
Ne parliamo con la Dott. Polick, angiologo della Clinica Guarnieri.
QUALI SONO I SINTOMI?
Quando parliamo di arteriopatia, ci riferiamo a un termine generico che indica una malattia che può interessare le arterie in diverse parti del corpo.
Nelle arteriopatie, le pareti dei vasi sanguigni possono restringersi fino a chiudersi completamente a causa dell’accumulo di depositi di materiali trasportati dal sangue.
Quando questa condizione colpisce le arterie degli arti inferiori, può manifestarsi un sintomo noto come “claudicatio”. Le persone affette da questa affezione possono camminare per una certa distanza, che varia da individuo a individuo, prima di doversi fermare a causa di un dolore muscolare. Il dolore può interessare l’intero arto o solo la gamba, a seconda della posizione e della gravità dell’occlusione arteriosa.
Dopo un breve periodo di riposo, il dolore di solito scompare, ma poi ricompare dopo un tratto di cammino simile. Con il passare del tempo, questo sintomo tende a peggiorare, e il dolore si presenta sempre più precocemente durante il cammino. Nelle fasi più avanzate della malattia, se non trattata, il dolore può comparire anche a riposo.
QUALI L CAUSE?
La causa principale dell’arteriopatia periferica è spesso l’arteriosclerosi. Questa è una malattia caratterizzata dall’accumulo di materiali nel sangue all’interno delle pareti delle arterie.
La stessa arteriosclerosi può colpire anche le coronarie, le arterie del cuore, causando condizioni come l’angina pectoris o l’infarto miocardico. Inoltre, può interessare le arterie carotidi, che trasportano il sangue al cervello, contribuendo a molte condizioni di ictus.
L’arteriosclerosi è una condizione che può avere un impatto significativo sulla salute vascolare in diverse parti del corpo, e il suo trattamento e la prevenzione sono importanti per ridurre il rischio di complicazioni legate a questa malattia.
LA DIAGNOSI
La diagnosi dell’arteriopatia periferica inizia con una visita chirurgica vascolare in cui si raccoglie l’anamnesi del paziente e si esegue un esame obiettivo. Un importante strumento diagnostico è l’ecocolordoppler, che fornisce al medico informazioni cruciali per determinare la terapia più appropriata.
Durante la visita, è essenziale misurare la pressione arteriosa sia alle braccia che alle caviglie. L’indice caviglia-braccio viene calcolato come rapporto tra la pressione sistolica alla caviglia e quella al braccio. Una deviazione patologica da questo indice può indicare la presenza di arteriopatia periferica.
L’obiettivo principale della terapia è il controllo dei sintomi, come crampi dolorosi e difficoltà nella deambulazione. Questo aiuta il paziente a riprendere una vita più normale.
È anche importante interrompere la progressione dell’aterosclerosi per ridurre il rischio di complicanze. Il trattamento può variare a seconda della gravità della malattia. Per i casi lievi, possono essere sufficienti modifiche dello stile di vita, come miglioramenti nella dieta e nell’attività fisica. Nei casi più gravi, potrebbe essere necessaria una terapia farmacologica o addirittura un intervento chirurgico, specialmente se l’arteriopatia periferica è avanzata.
Il paziente dovrebbe essere monitorato nel tempo, e se si manifestano sintomi come la claudicatio, è importante rivolgersi al medico per avviare una terapia adeguata.
La diagnosi precoce e una gestione appropriata dell’arteriopatia periferica sono fondamentali per prevenire complicazioni gravi e migliorare la qualità della vita del paziente.
COME SI CURA L’ARTERIOPATIA PERIFERICA?
Il primo passo nella gestione dell’arteriopatia periferica è eliminare i fattori di rischio più comuni come il colesterolo elevato, il diabete e il fumo. Nei casi più complessi, è possibile anche considerare l’uso di farmaci antiaggreganti o vasodilatatori.
Quando si verifica una significativa occlusione delle arterie, diventa necessario un intervento chirurgico di rivascolarizzazione. Questo può includere l’angioplastica, l’uso di stent o, nei casi più gravi, un bypass.
L’angioplastica è una procedura chirurgica utilizzata per aprire un’arteria ostruita. Durante questa procedura, un sottile tubo flessibile chiamato catetere viene inserito attraverso un vaso sanguigno fino al punto in cui l’arteria è ristretta. Un palloncino alla punta del catetere viene quindi gonfiato per dilatare l’arteria, rimuovere la placca di aterosclerosi e ripristinare il flusso sanguigno normale. A volte, viene inserito uno stent, una struttura a maglie, per mantenere l’arteria aperta.
L’intervento di bypass, d’altra parte, consente al sangue di bypassare l’area ostruita o ristretta dell’arteria creando un percorso alternativo. Questo viene fatto inserendo un vaso sanguigno (che può provenire da un’altra parte del corpo del paziente o essere sintetico) per collegare le due sezioni sane dell’arteria, evitando così l’area ostruita.
Quando è presente un coagulo di sangue che ostruisce l’arteria, il medico può utilizzare un farmaco per sciogliere il coagulo nel punto critico, ripristinando così il flusso sanguigno.